>>
torna a conferenze
APPUNTI SULLA TOSSICODIPENDENZA
1 - INTRODUZIONE
Una revisione sulla letteratura psicoanalitica sui tossicomani e la(e)
tossicomania(e), presentano il problema che partendo da un livello di
analisi centrato sull’individuo o sul gruppo familiare non fanno
che distorcere e nascondere il problema, anziché spiegarlo, mostrarlo,
renderlo evidente.
Si afferma così che il tossicomane rimpiange un paradiso perduto,
ciò spiegherebbe il suo lato malinconico, o che il padre o la madre
sentono il figlio come un “incidente” che devono accettare,
o che il tossicomane sia il sintomo emergente di una famiglia psicotica
o il risultato di una serie di lutti non elaborati, o infine, il figlio
di un padre anziano, incapace di soddisfare sessualmente la madre o incapace
di offrire un modello di identificazione sessuale.
Secondo noi, in questo modo si colpevolizza indirettamente la famiglia.
Da un livello di analisi individuale, la tossicomania è stata definita
come un’organizzazione narcisista delle strutture infantili della
personalità, che può eliminare la parte considerata adulta
nel controllo del comportamento.
Si sostituisce così la dipendenza verso le parti interne della
personalità considerate “buone”, per la passività
verso le parti “cattive” del self, portando alla disperazione.
In questo modo si colpevolizza indirettamente l’individuo che viene
considerato “perverso”, a volte come vittima o nel migliore
dei casi come l’elemento più debole della catena sociale.
- KARL VON CLAUSEWITZ, affermava nel suo trattato che “la guerra
è la continuazione della politica con altri mezzi”.
Possiamo pensare, senza paura di sbagliare che l’attuale impero
della droga, oggi, forse non è altro che la continuazione della
politica attraverso altri mezzi.
2 - ALCUNI DATI STATISTICI
I tossicodipendenti da eroina in Italia si calcolano intorno ai 500.000.
di questi 40.360 sono seguiti nei centri pubblici o privati (dati relativi
al 30-06-1989).
L’età media nella quale si comincia a far uso di droghe pesanti
(“il buco di eroina”) è tra i 14-15 anni, o durante
il servizio militare intorno ai 18-20 anni.
Per “over-dose” muoiono due tossicodipendenti al giorno, che
hanno un’età media di 26 anni nell’anno 1985 e di 27
nel 1988.
Questa salita che i morti sono giovani con lunghi anni di esperienza nella
tossicodipendenza.
Il numero di morti per over-dose sono stati 542 nell’anno 1987;
797 nell’anno 1988, e a giugno 1989 si arriva a 408. Nel 1990 si
arriva a 1152.
Il fatturato del traffico italiano della droga è di 30.000.000
(trenta milioni di dollari all’anno, fonte CENCIS); essendo il fatturato
mondiale di 500.000 milioni di dollari all’anno (calcolo ONU).
Inoltre, nell’insieme della criminalità italiana, ogni dieci
reati commessi, otto sono in rapporto alla droga.
Fino all’anno 1970 in Italia non c’erano eroinomani.
Sempre nel 1970, arriva a Roma il primo carico di eroina e tra gli anni
1974-1975 si verifica il fenomeno della diffusione massiva , per arrivare
verso la fine dell’anno 1975 a circa 20.000 eroinomani in Italia.
3 - Questi dati statistici ci pongono alcune domande
- Come si spiega questa diffusione massiva dell’eroina in Italia?
- A che interessa l’offerta dell’eroina agli adolescenti?
- Perché questo fenomeno si presenta proprio intorno agli anni
’70?
- Perché in questi ultimi anni i mass media hanno sottolineato
il fenomeno della morte da over-dose?
- Perché si muore da over-dose dopo una lunga esperienza di droga,
cioè tra i sei e i dieci anni?
- Forse c’è un rapporto tra droga e politica?
- Quale potrebbe essere questo rapporto?
4 – L’EROINA, UN PROBLEMA POITICO
La mafia dell’eroina si caratterizza negli anni ’80 come un’impresa
multinazionale che opera a livello internazionale con le caratteristiche
comuni a qualsiasi impresa.
L’inizio di quest’attività comincia nell’anno
1957, in cui 57 “boss” della mafia italoamericana, riunitisi
a New York, prendono la decisione di operare nel mercato dell’eroina.
La scelta dell’eroina, derivato dell’oppio che si coltiva
nel sud est asiatico, implica un rifiuto della cocaina che si produceva
nell’America Latina, ciò per ragioni precise: si sceglie
l’eroina nonostante il lungo viaggio dai paesi produttori fino ai
paesi centrali consumatori, perché si pensa che l’eroina
più che la cocaina, offra la possibilità di diventare una
droga di uso massivo.
La cocaina, più elitaria, non dava in quel momento tale garanzia.
Il mercato consumatore: EUROPA e STATI UNITI.
Il ritorno dei soldati americani dal Vietnam, già eroinomani in
percentuale del 15%, favorisce in un secondo momento la sua diffusione.
Per capire questa scelta bisogna analizzare la politica internazionale
in quegli anni.
Pensiamo che questa decisione della mafia italoamericana non sia casuale,
ma coincidi con un momento politico particolare, alla controffensiva dell’imperialismo
nella sua lotta contro i paesi del patto di Varsavia, la cosi detta “guerra
fredda” contro i paesi dell’est. E contro il nemico interno
dei paesi del Patto dell’Atlantico del Nord: la NATO.
In particolare uno delle maggiori preoccupazioni degli Stati Uniti in
Italia, appena finita la seconda guerra mondiale era la presenza del Partito
Comunista nelle forze della resistenza.
Nel 1948 si verifica l’alleanza tra la mafia siciliana e una parte
della Democrazia Cristiana e attraverso questi canali, o direttamente,
con la mafia degli USA e la loro politica.
Nasce in questi anni il rapporto ufficiale tra la mafia e la politica:
le due facce dello Stato (o lo stato schizofrenico).
Con l’assassinio di Salvatore Giuliano nel 1950, si sigilla il patto
tra un settore della Democrazia Cristiana e la mafia.
La ricchezza accumulata con il traffico di eroina fa sì che la
mafia si vada ricostruendo come un partito, un partito armato che concentra
in se stesso potere economico, politico e militare.
In questo momento la guerra fredda fa ormai parte del passato e nell’Europa
della NATO le forze popolari non hanno proposte che possano mettere in
discussione il sistema politico; questo comporta che il nemico interno
non ha più motivo di essere combattuto con la droga in senso ampio,
cioè il consumismo, o con il consumo degli stupefacenti cioè
la droga in senso ristretto.
Per questo i governi prendono provvedimenti contro il “consumo”
della droga.
La guerra agli stupefacenti dell’attuale amministrazione Bush ha
altri obiettivi:
a) in America Latina serve per giustificare l’intervento militare
contro i popoli in lotta, o per recuperare obiettivi strategici –
per esempio il canale di Panama.
b) In Europa, con l’effettiva smobilitazione popolare, non è
più necessario il controllo dei giovani con l’eroina. Per
questo si propongono leggi nuove, repressive per i tossicomani e non per
la mafia.
Questa, con il potere accumulato in 20 anni di traffico non è disposta
a rinunciare al suo traffico e diventa uno scomodo interlocutore a cui
bisogna offrire nuovi mercati.
L’apertura delle frontiere con i paesi dell’Est, la frattura
del monolitismo ideologico e la rinascita delle contraddizioni secondarie,
offrono un terreno fertile per l’introduzione massiccia della droga.
Cambiano così le forme di lotta contro i paesi dell’Est.
Da guerra esterna si trasforma in guerra interna, diventando impossibile
introdurre le stesse forme di controllo che furono utilizzate negli anni
’70 all’interno dei paesi della NATO.
Questo controllo si effettua principalmente sui giovani poiché
sono loro il potenziale creativo e di rinnovamento della società.
5 - LA TOSSICOMANIA COME ESPRESSIONE DELLA CRISI DI IDENTITÀ DELL’ADOLESCENTE
Le considerazioni generali fatte in precedenza ci permettono di affermare
che il fenomeno della tossicodipendenza così come la osserviamo
dai paesi industrializzati non dipende da motivazioni individuali o da
una particolare struttura della famiglia o della personalità.
Vista da questa prospettiva possiamo pensare che la tossicomania è
la conseguenza del rapporto tra un progetto pianificato di annullamento
della capacità di lotta delle nuove generazioni che si incontra
con la crisi di identità dell’adolescenza.
La crisi adolescenziale significa nella sua essenzialità, lasciare
l’infanzia, il corpo e il mondo infantile, per scegliere un’identità
sociale adulta.
L’assenza dei modelli di identificazione, l’assenza di movimenti
di massa, l’assenza di utopie sociali, in rapporto alla presenza
di eroina che dà ai giovani un’identità sociale riconosciuta,
un codice comune un’appartenenza ad un gruppo.
L’eroina diventa in questo modo un elemento magico, onnipotente
che risolve ogni problema, ogni cosa. Attraverso l’eroina l’adolescente
può confrontarsi con la morte e in questo confronto conoscere sé
stesso e i propri limiti.
In questo piacere di “morire”, al confrontarsi con le situazioni
limite, per questo, la tossicomania si avvicina ai rituali di iniziazione
delle diverse società. Il confronto con la morte permette di conoscere
i propri limiti, di “morire” come bambino e rinascere come
adulto.
L’identità è il risultato di una lunga storia individuale,
familiare e sociale. Le successive identità parziali che il bambino
va costruendo attraverso la sua storia si riorganizzano nell’adolescenza
includendo il sociale generale o l’essere collettivo che darà
coerenza e significato alla personalità.
Nella crisi adolescenziale, tutta la storia del soggetto deve riorganizzarsi,
integrando il passato individuale, famigliare e sociale in una nuova struttura
della personalità.
L’adolescente, deve, alla fine scegliere un modo di essere nel mondo,
deve costruire un progetto di vita, che sia una sintesi tra passato, presente
e futuro.
L’adolescente lotta e cerca di lasciare il modello di dipendenza
– rappresentativo del suo passato infantile_ per acquistare un’identità
propria, che includendo il suo passato, lo contenga, lo integri e lo superi.
Questo sarà il contributo generazionale che, individuale o collettivamente,
è precisamente il compito dei giovani.
È proprio in questo momento che l’adolescente cerca e ne
ha il bisogno, di modelli di identificazione, che lo possano aiutare in
questa tappa dura, dolorosa e difficile che è la costruzione della
sua identità adulta.
È in questo momento che il giovane si interroga:
- Chi sono io?
- Chi voglio essere?
- Chi non voglio essere?
- Come voglio essere?
- Come non voglio essere?
Le osservazioni che ho potuto effettuare nelle quali c’era o c’era
stata lotta popolare, l’adolescente si può dare queste risposte:
- Io sono parte della lotta del popolo.
- Io sono del popolo
- Io voglio essere parte della lotta del popolo.
- Io sono sandinista
- Io sono peronista rivoluzionario, ecc.
L’adolescente può così superare la dipendenza familiare,
partecipando creativamente all costruzione della società.
Trasformando attivamente la realtà e in questa pratica costruirsi
e trasformarsi a se stesso raggiungendo un’identità.
In questo modo, inoltre il giovane mette alla prova le sue capacità,
conosce i suoi limiti e le sue paure, scopre le sue potenzialità
mettendo la sua vita alla prova, ha dunque la possibilità simbolica
di morire come bambino e adolescente, per rinascere come adulto creativo,
conquistando in questo modo e costruendo la sua propria e autentica identità.
– (vedere Appendice N. 1) –
Tutto ciò significa la trasformazione della realtà in piacere
e il desiderio in realtà.
Cosa succede con l’adolescente italiano?
Una frase ricorrente nel linguaggio dei tossicodipendenti è: “mi
buco per riempire i vuoti”.
Questi vuoti diventano interni come conseguenza del vuoto esterno che
consiste nell’assenza di modelli di identificazione, l’assenza
della lotta popolare, l’assenza dell’utopia sociale. –
(Vedere Appendice N. 2) –
L’eroina che fa “vivere in un altro modo”, risolve in
modo magico e onnipotente questi vuoti: con lei, l’adolescente cerca,
senza trovare, la sua identità. Si annulla così il progetto
di vita che si trasforma in progetto di morte. Si annulla il potenziale
creativo, portando progressivamente alla disperazione e all’autodistruzione.
6 - LA TERAPIA DEI TOSSICODIPENDENTI
Abbiamo proposto in Italia un modello di terapia dove l’agente terapeutico
non è , né un individuo né un gruppo, ma la Comunità
terapeutica nella sua totalità.
In questa sia gli assistiti – i pazienti- che il personale, i terapeuti,
sono gli agenti del cambiamento, essendo la salute un progetto sociale
e collettivo.
Ciò che guarisce è un processo pratico di vita comune, dove
l’assistito può capire la sua vita, ricostruire il suo gruppo
interno e principalmente riscoprire e sviluppare le sue capacità
creative in un’esperienza pratica di partecipazione sociale. Sarà
così possibile, attraverso una prassi, pensiero e azione, costruire
un progetto creativo, sulla base della dignità dell’essere
umano, il rispetto e l’amore alla vita, la solidarietà, il
diritto e il dovere al lavoro, la socializzazione e il diritto alla partecipazione
sociale.
APPENDICE N. 1
In Nicaragua, paese dove c’è un’utopia sociale, dopo
la Rivoluzione Nazionale Sandinista del 1979, gli adolescenti non sono
più un terreno fertile per l’introduzione della droga.
A causa della dittatura precedente di Somoza la Rivoluzione Sandinista
si trova con un’eredità gravosa, cioè, i bambini e
i giovani delinquenti i “huele pega”- dipendenti da colle
inalate.
La rieducazione di questa parte della popolazione è il reinserimento
nell’utopia sociale, essendo questa la risoluzione non solo di questo
problema e di questa conflittualità, ma anche per la problematica
pscopatologica in generale, come hanno dimostrato tutte le pratiche precedenti.
(Il mio lavoro nel Ministero degli Affari Sociali per la rieducazione
dei minorenni e come l’esperienza dell’équipe degli
internazionalisti del Messico in Nicaragua).
APPENDICE N. 2
Quelli che sognano in Italia.
Forse gli unici che sognano sono quelli del Movimento Sociale Italiano.
Il suo attuale segretario disse nell’ultimo congresso del Partito:
“Si chiede, signori, un grano di utopia, di lucida, lungimirante,
limpida, ragionevole utopia.
Che cos’è quello voglio?
Dare un futuro al nostro passato (…).
Oggi un giovane comunista si può chiedere:
“tanti anni di lotta per diventare socialdemocratici?
Approfittiamo della crisi del comunismo, raccogliamo noi l’audacia
che il marxismo ha perso.”
APPENDICE N.3
…E quelli che realizzano loro sogni:
il Papa Wojytila commenta il “fallimento delle grandi ideologie”
(Repubblica 13/01/1990). Titolo: il papa elogia Casaroli: ha seminato
bene”.
Affrontando la grande questione della OSTPOLITIK, il pontefice ringrazia
Casaroli, segretario di stato designato da lui stesso nel 1979, in questo
modo:
“Quanto avviene in questi giorni ad Est è frutto di una paziente
semina che è stata fatta per il bene degli uomini e dei popoli
dai Responsabili della Chiesa e della Santa Sede”.
Continua poi Wojytila: “Le grandi ideologie hanno mostrato il loro
fallimento dinanzi alla dura realtà degli avvenimenti, dei sistemi
sedicenti scientifici di rinnovamento sociale o sia di redenzione dell’uomo
con le sole sue forze, dei miti di realizzazione rivoluzionaria dell’uomo;
delle fragili utopie che hanno portato ad un regresso senza precedenti
nella storia tormentata dell’umanità”
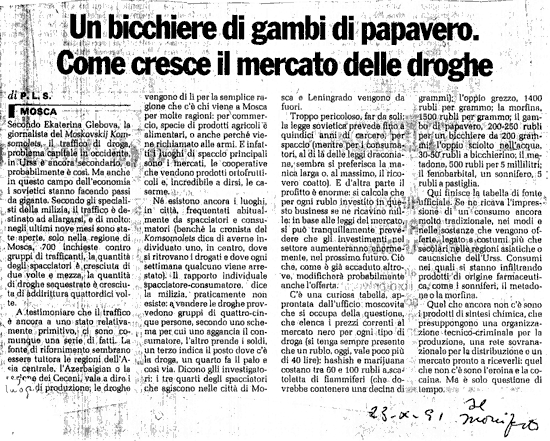
BIBLIOGRAFIA
Blumie G., Rusconi M.: La droga e il sistema.
Milano. Clubs degli Editori 1980
Cancrini Luigi: Tossicomanie.
Editori Riuniti. Roma 1980
Lamour C., Lamberti M.: Il sistema mondiale della droga
Einaudi. Torino 1974.
La Repubblica: Le cifre di una battaglia persa
07.09.1989
La Repubblica: Congresso del M.S.I.
13.11.1990
L’Unità: Morti per droga
02.10.1989
L’Unità: I cannoni antidroga.
11.11.1989
Meltzer, Donald: Il processo psicoanalitico
Armando. Roma 1981
Meltzer, Donald: Stati sessuali della mente
Armando. Roma 1981
Olivenstein, Claude ed altri: La vita del tossicomane.
Libreria Editrice Lauretana, Loreto 1987
Pantoleone Michele: Mafia e droga.
Einaudi. Torino 1979
Sartori Maria Gabriella: Progetto Pilota, Prevenzione della devianza
minorile
Treviso 1985
Sartori Maria Gabriella: Una specifica esperienza carceraria e gli effetti
della personalità
Tesi di laurea in Psicologia. Padova 1978
Violante Luciano: La mafia dell’eroina
Editori Riuniti. Roma 1987

